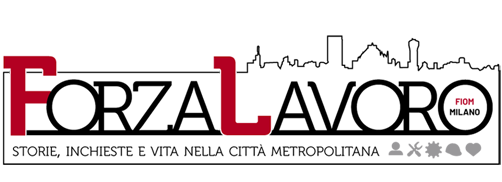5. Una storia di ordinaria consulenza
Sara Del Dot, Marta Facchini, Mattia Guastafierro
“Nei primi anni non staccavo mai il telefono. Non lo facevo perché avevo paura. È capitato più volte che mi rimproverassero, se non fossi reperibile. Tenevo tutto acceso, avevo l’ansia di rispondere alle mail e ai messaggi. Oggi posso dire di essere stufa di sentirmi una pedina nelle mani di qualcuno. Non ho più il timore di vivere quel condizionamento psicologico. Se non rispondo, non esplode il mondo. Se porto a termine un compito domani, invece che oggi, non muore nessuno”.
Ci sono voluti tre anni e tanta consapevolezza in più ad Arianna (nome di fantasia, ndr) per liberarsi dalla morsa della consulenza. Ventitrè anni, milanese, laureata in Lingue, anche lei – come tanti altri consulenti che abbiamo intervistato – descrive così il suo ex ambiente di lavoro: “Tossico, gravoso e per nulla solidale”. Dopo 36 mesi, trascorsi al limite del burnout, ha trovato oggi la forza di licenziarsi. La incontriamo su Zoom, un pomeriggio di metà luglio: per lei sono gli ultimi giorni in azienda e lavora spesso da casa. Per l’intervista ha chiesto un permesso di qualche ora, ma sul pc continuano ad arrivare messaggi. La differenza è che oggi le richieste del cliente o le pressioni del capo non la preoccupano più.
– Se il mondo della consulenza è davvero un inferno come racconti, perché hai deciso di entrarci?
Perché mi ero appena laureata e volevo fare un’esperienza nel mondo dei grandi. Facevo la hostess al Duomo di Milano. L’azienda per cui lavoravo (una delle principali società di consulenza di base a Milano, ndr) nemmeno la conoscevo. Mi sono candidata su consiglio di un amico. Mi ha detto: ‘Qui assumono anche senza esperienza e pagano bene’. Così ho applicato per una posizione da marketing analyst. Non ne sapevo nulla ma al colloquio mi hanno detto che sembravo ‘volenterosa’.
– E in effetti è andata così: ti hanno assunta senza particolari difficoltà. Ma di che cosa ti occupavi nello specifico?
Il mio ruolo, fino a poco prima di dimettermi, era Digital business integration specialist. Che cosa vuol dire? Nel concreto, niente. Il mio contributo era effimero. Fissavo i meeting e coordinavo i tecnici che avevano il compito di risolvere i problemi di software o implementare i file di codice. Dicevo: ‘tu controlla questo, tu quest’altro’ e poi verificavo che tutto fosse al proprio posto. Insomma facevo da raccordo tra la società di consulenza e l’azienda cliente.
– Gli inizi come sono stati?
Molto duri. Appena assunta, mi hanno spedita in trasferta a Dusseldorf in Germania, nell’azienda del cliente, un sito e-commerce. Mi occupavo di materie strettamente tecniche: interfacce di prodotto, export dei prezzi, piattaforme di back-end. Niente a che vedere col marketing, per cui ero stata assunta. I primi tre mesi sono stati i più difficili: arrivavo a lavoro e non capivo niente. Non avevo ricevuto un’adeguata formazione e ogni giorno i miei colleghi dovevano insegnarmi tutto. Ho fatto un anno così. Poi quando è scoppiata la pandemia, sono passata in smart working e le cose sono anche peggiorate. Non c’era più nessuno a salvarmi. Dovevo cavarmela da sola. Google è diventato il mio migliore amico.
– Gli orari come sono?
Se un consulente vi racconta che il suo orario è 9-18, non credetegli. È un miraggio. I miei turni sono sempre stati estremamente flessibili e lo sono diventati ancora di più in remoto. “Tanto sei a casa, che cosa devi fare?”, mi diceva l’azienda. Il telefono squillava alle 21, le mail arrivavano fino alle 22. Spesso le comunicazioni viaggiavano su canali informali come WhatsApp. Il mio lavoro però è rispondere. E se c’è da lavorare oltre il tuo turno, lo devi fare. Persino nel fine settimana. È una condizione accettata da tutti, consapevolmente e non. Purtroppo manca la protezione dei colleghi senior. Nessun manager ha mai detto a qualcuno di non scrivermi nel weekend perché non sarebbe stato corretto.
– Gli straordinari almeno sono pagati?
Dipende dal progetto. E soprattutto dal contratto col cliente. Se la commessa è ricca, sì, a volte vengono pagati. Altrimenti mai. Pensate che sono persino arrivati a dirmi di segnare gli straordinari in banca ore, in modo da ottenere in futuro dei giorni di ferie in più. Io mi sono ribellata e solo così sono riuscita a strappare qualche sabato retribuito. Ma ho potuto fare la voce grossa solo perché i colleghi sul progetto a cui ero assegnata erano appena arrivati. Senza di me, non avrebbero saputo dove mettere le mani. Così non hanno potuto fare altro che accontentare le mie richieste. Non tutti però hanno il coraggio di fare ciò che ho fatto io.
– Perchè? Non c’è la consapevolezza di subire un ingiusto trattamento?
Il problema è che sei inserito all’interno di un contesto psicologico altamente stressante. Ci sono diversi step di crescita in azienda. All’inizio parti come analyst, per poi diventare nel giro di un paio d’anni consultant. Tradotto: contratto a tempo indeterminato più scatto di stipendio. Quando sei analyst, tutto il tuo lavoro è monitorato in funzione della promozione. I manager stilano una serie di classifiche e a ciascuno viene assegnato un punteggio. In base alla graduatoria, si decide chi promuovere. A me è capitato tre volte di essere scavalcata da persone assunte con me o dopo di me, mentre io rimanevo indietro. Cerchi di non fartela pesare, ma non è semplice. Anche inconsciamente avverti un condizionamento psicologico. Arrivi a pensare che hanno fatto meglio di te, che stai sbagliando qualcosa e che forse devi dare di più. Ti senti in colpa, ingiustamente, e allora ti metti sotto. All’inizio non me ne rendevo conto. Poi capisci che spesso la promozione è solo una questione politico-economica: va avanti con più facilità chi lavora sui grandi progetti che portano all’azienda maggiori entrate.
– Sono queste le più grandi contraddizioni del lavoro da consulente?
Al primo posto c’è di certo lo stress da lavoro correlato, ma le criticità sono tante. Ad esempio manca del tutto il supporto dei più esperti verso i più giovani. L’ambiente non è sano, non c’è solidarietà. Ho incontrato tanta gente competitiva e cattiva. Al contrario, la comunicazione aziendale cerca di diffondere verso l’esterno tutta un’altra gamma di valori: sui canali social troverete solo video di dipendenti felici e sorridenti che presentano la società come una grande famiglia, aperta e ricca di opportunità. Settimanalmente i manager promuovono poi degli eventi per celebrare lo spirito solidale e innovativo dell’azienda. Ma non è così. È tutta propaganda.
– Ci saranno almeno dei lati positivi?
Sì, certo. I soldi, innanzitutto. Con zero esperienza, guadagnavo 28mila euro l’anno. Sono circa 1.500-1.600 euro netti al mese. Dopo due anni, anche se non ottieni la promozione, ricevi comunque un aumento pari a 500 euro lordi l’anno. E poi di certo c’è l’esperienza. Ti buttano nel frullatore ma, se resisti, impari molto. Il gioco, però, almeno per me non valeva la candela.
– Qual è l’esperienza peggiore che ti porti dietro?
Di certo la trasferta in Germania. Ero stata assunta da appena sei mesi. Nel corso di un meeting con il cliente, a cui non partecipava il mio superiore, mi sono ritrovata a dover rispondere a richieste di cui non avevo responsabilità. Un dipendente ha incominciato a urlarmi in faccia che ero una incompetente, un’incapace. Sono scappata via, umiliata. Ciò che più mi ha fatto male, però, è stato il fatto che nessuno mi abbia difeso, nemmeno i colleghi che conoscevano la mia situazione. Quel giorno in hotel volevo licenziarmi. Ma ho resistito. (5-continua)
Sara Del Dot, Marta Facchini, Mattia Guastafierro.